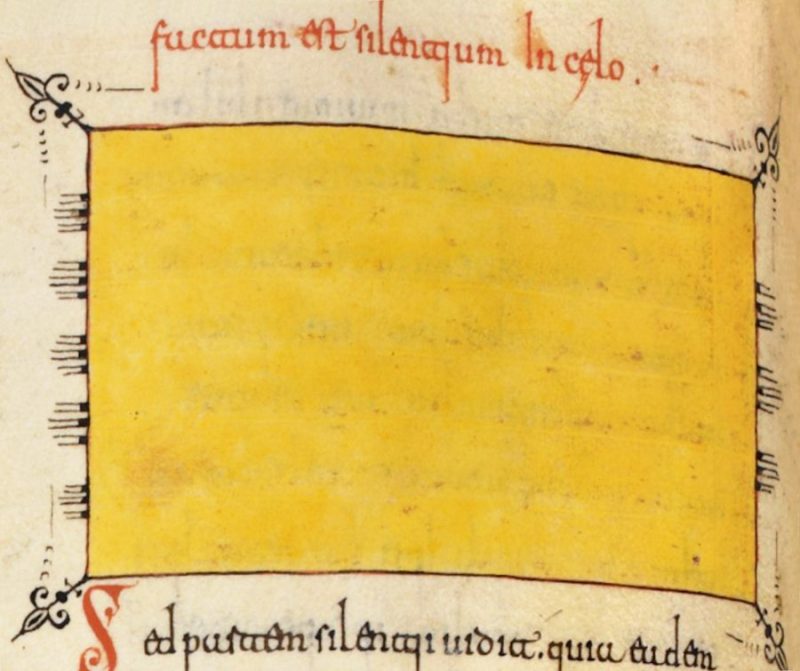Vedi alla voce «Resistenza» o anche «Liberazione» e vedrai delle immagini; poche, sgranate e tendenzialmente ripetitive. Vedi a quella voce lì anno dopo anno per una lunga serie di anni e ti sarai formato un’idea della Resistenza che non è propriamente un’idea quanto piuttosto un immaginario: l’immaginario resistenziale.
* (Introduzione al volume Il sorriso dei partigiani, Red Star Press, 2013)
La fotografia è un sogno, il sogno di quello che abbiamo creduto in certi momenti della nostra vita, e così emergono dal passato improbabili pettinature, gesti blasfemi o situazioni che al nostro io attuale appaiono sgraziate, impossibili o altere. Portatrici non più di un sogno ma in certi casi – come certi grandi amori finiti in tragedia – di un incubo, un male, un dolore inconciliabile. Ecco così che dagli album di famiglia dell’era predigitale emergono teste ritagliate, foto di coppie un tempo abbracciate e ora improvvisamente monche, assenze misteriose nella consecutio temporum della scansione narrativa della nostra o dell’altrui vita. Nell’era digitale della pervasività totale delle immagini nelle nostre vite cancelliamo con un click album digitali, amicizie reali e virtuali ed effettuiamo sostituzioni in corsa della nostra rappresentazione. Sogni intercambiabili seppure incancellabili, ché la rete si dice, ricorda tutto.
E questo è quello che succede dopo che la fotografia è stata presa. Ma il processo di censura della realtà e di selezione di un sogno invece di un altro avviene già in fase di ripresa. Ci sono poche, pochissime immagini dei nostri genitori intenti nelle loro attività quotidiane, mentre ce ne sono un’infinità della loro vacanza all’estero o del pranzo al ristorante con tutta la famiglia. Nell’era predigitale una foto aveva un costo vivo, un costo industriale che spingeva ad una cautela ancor più radicale. La foto in altri termini non andava assolutamente sprecata. Non è questa la sede per discettare sull’epocale cambio paradigmatico del passaggio tra analogico e digitale, visto che per l’argomento trattato restiamo ben ancorati a un mondo, quello dell’Italia tra il 1943 e il 1945, ben più che analogico.
Torniamo dunque al nostro immaginario resistenziale, a come si è costruito e a come è giunto fino a noi.
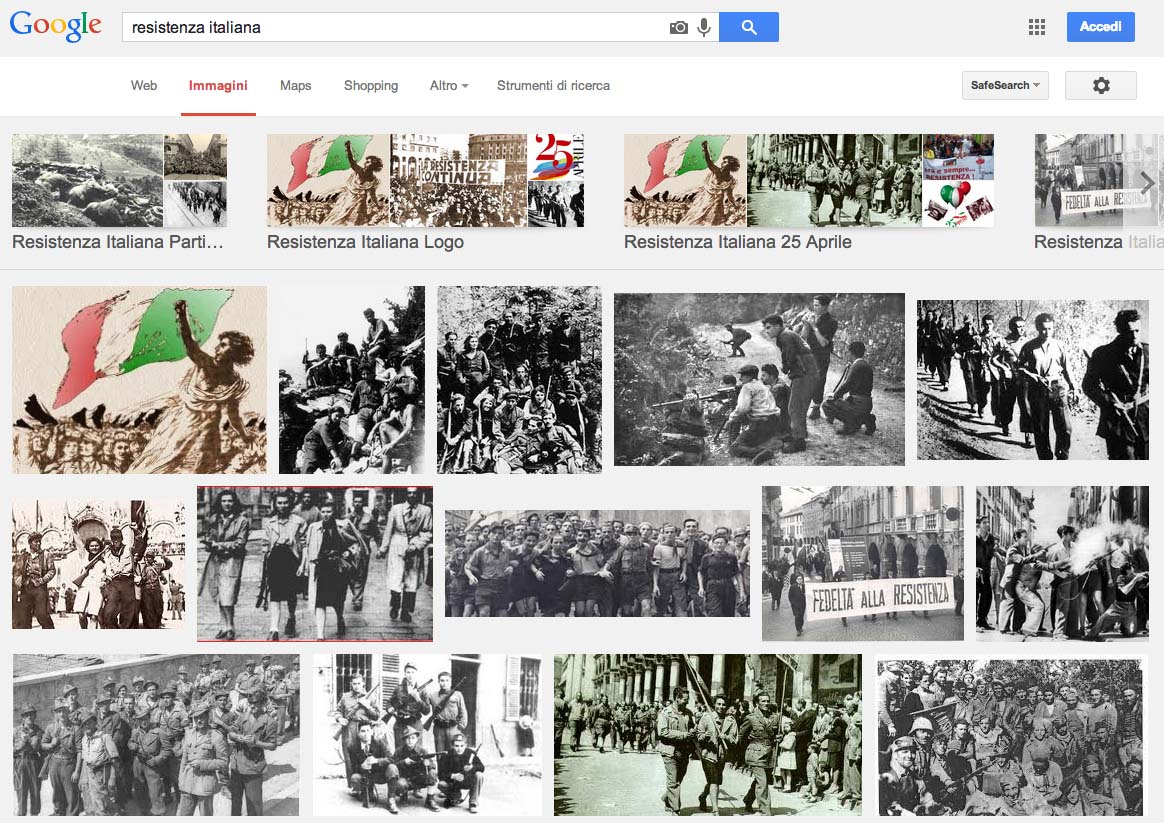
Viva i partigiani! Ma i fotografi?
[dropcap]I[/dropcap]n primo luogo la Resistenza fu un fatto di popolo e non di istituzioni. Da ciò ne consegue che nelle città e nelle montagne non combatteva l’Esercito, ma una moltitudine di bande armate. L’Esercito, in quanto istituzione, ha una necessità storica, propagandistica e antropologica di documentare ciò che fa. Al seguito delle truppe dell’Asse e di quelle Alleate agivano fotoreporter e cineoperatori, a volte di grande efficacia (basti pensare alle incredibili immagini dello sbarco in Normandia su Omaha beach di Robert Capa). Prima ancora dei fotografi gli eserciti avevano al seguito pittori e artisti, sempre allo scopo di documentare le vittorie e gli andamenti bellici. Oggi, con una punta di disprezzo, questi professionisti vengono definiti embedded, in quanto non più al soldo dell’esercito ma delle news corporation, il che aggiunge appena una sfumatura di ambiguità a quanto già detto.
Le nostre truppe partigiane non avevano unità di fotoreporter o di cineoperatori. Le avevano i fascisti però, e infatti delle gesta delle camicie nere repubblichine abbiamo immagini di grande professionalità e notevole impatto. L’Istituto Luce d’altronde è ancora al suo posto. (Per inciso Pasquale Chessa nel suo libro Guerra civile. Una storia fotografica ipotizza non senza una certa ovvietà che le squadre di fotografi che operavano per la Repubblica Sociale passarono ai partigiani subito dopo il 25 aprile, d’altronde perché non avrebbero dovuto farlo?).
Poveri partigiani, senza armi e senza foto. Certo all’epoca a nessuno sembrava importante avere degli apparecchi fotografici caricati a metri di rullino e qualche laboratorio clandestino di sviluppo e stampa. Ma se li avessero avuti questo avrebbe contribuito a modificare almeno in parte quell’immaginario resistenziale che, per vari motivi che vedremo in seguito, risulta quantomeno claudicante? Probabilmente no. Perché una foto non è la realtà ma rappresenta la realtà. E quella rappresentazione la decide qualcuno. La decide in genere il potere.

Insomma, chi le ha fatte quelle foto, e perché?
[dropcap]L[/dropcap]e foto che sono giunte fino a noi sono state realizzate dai partigiani stessi. Sono foto ricordo, scattate con gli stessi principi che animavano la ripresa fotografica amatoriale a quell’epoca (e in quest’epoca, anche con Instagram). Ovvero dare di se stessi e dei propri amici la migliore versione possibile. E quando si dice «migliore versione» si deve pensare a cosa si intendesse negli anni Quaranta con questo termine.
Poi ci sono le foto realizzate da professionisti, fotografi di matrimoni e di ritratti, in studio (che poi «studio» era spesso all’aperto con dietro un telo, visto che di fari, riflettori e flash statici non si parlava ancora). Queste foto sono state realizzate in due momenti distinti, ovvero prima che il partigiano partisse per la montagna o entrasse in clandestinità e dopo la fine della guerra. Nel primo caso la foto veniva realizzata come «ricordo» da lasciare ad amici e parenti nel caso affatto remoto che ci si morisse in guerra. Questa pratica è diffusa in Occidente dall’alba dei tempi e nei secoli ha dato lavoro e da mangiare a migliaia di professionisti del ritratto, sia disegnato che fotografato. L’immagine risultante è «santa», perché doveva adattarsi a vari usi, dai documenti istituzionali, alla fidanzata, alla lapide del cimitero. Non c’erano certo i soldi per farne più d’una! Pensateci: state per andare in guerra e probabilmente non tornerete vivi. Dovete lasciare un ricordo, qualcosa che testimoni il vostro passaggio sulla terra. Difficilmente sarà una foto dove mostrate il dito medio con in mano una birra.
Poi dalla guerra ci siete tornati, e avete pure vinto. Tornate dal fotografo, nel suo studio, che poi è il telo del cinematografo, e fate una seconda foto. Quella che credete in quel momento essere l’unica seconda foto della vostra vita. Queste immagini, ampiamente diffuse e ampiamente confuse con foto di «partigiani» sono di fatto foto di «ex partigiani». I soggetti sono ben lavati, eleganti nelle loro divise «buone», sorridenti all’eccesso e pieni di armi. Sono le foto di chi ha attraversato la guerra civile italiana ed è sopravvissuto. Se morissi domani sarò ricordato così, nel pieno del trionfo. È davvero molto interessante studiare queste immagini e nel libro vedrete come uomini e donne si abbracciano e partecipano alla realizzazione di queste immagini nella versione anni Quaranta e nel cuore di un’Italia bigotta e contadina, di situazioni al limite dell’orgiastico. Nella composizione di queste foto – le immagini del trionfo, quelle vere, non quelle delle parate o del discorso istituzionale – si ricorre a stereotipi di tipo cinematografico, ai grandi tableau vivants dei musical e dei varietà degli anni Trenta e Quaranta.
Questi due tipi di foto, il ritratto personale prima e dopo, sono il frutto della volontà popolare e contadina, riflettono quell’approccio e quel mondo. Poi ci sono altri due tipi di foto, l’istantanea e quella di propaganda. Cioè le immagini della borghesia.
L’istantanea, realizzata tra le formazioni partigiane nei momenti di riposo, tra una battaglia e l’altra, è l’irruzione della modernità borghese. Ci volevano soldi per possedere una macchina fotografica, e ci volevano soldi per acquistare i rullini. Poi bisognava sperare di conservare la vita e i rullini fino al termine del conflitto (che di svilupparli a guerra in corso era fuori discussione). Le istantanee partigiane sono rarissime, interessano quasi esclusivamente le formazioni armate del Nord Italia dove operavano reparti ben equipaggiati e il controllo del territorio era più rigido. Pochissime sono le foto di questo tipo giunte fino a noi. Soprattutto, pochissime sono quelle «rivelate»; perché a questo punto bisogna anche vedere, una volta che abbiamo stabilito chi scattava e perché lo faceva, il ruolo della propaganda. Che è anche il quarto tipo di scatto fotografico che prendiamo in considerazione.

Chi utilizza le foto partigiane?
[dropcap]M[/dropcap]entre i partigiani combattenti impegnavano le truppe naziste e repubblichine dietro le linee, nell’Italia già un po’ più libera, si delineavano strategie di propaganda e di intelligence, come si dice oggi. I problemi principali che da questo punto di vista doveva risolvere il cln erano due. Il sostegno della popolazione civile alle truppe partigiane (e quindi combattere la propaganda repubblichina) e convincere gli Alleati di essere in grado di governare l’Italia e soprattutto di meritarlo. Il regime fascista puntava le sue carte sul fatto che i partigiani fossero truppe irregolari, ribelli, poco più che banditi. Che quindi rubassero, stuprassero e via discorrendo. I partigiani venivano impiccati senza riconoscergli lo status di soldato combattente, al collo un cartello avvisava la popolazione civile: «bandito». Di conseguenza la disciplina nei reparti partigiani combattenti era – sotto questo aspetto – altissima. Se ci si macchiava di uno dei suddetti reati si veniva immediatamente e sommariamente passati per le armi. È vero che di immagini nell’Italia in guerra ne circolavano ben poche, ma su quelle immagini il Cln voleva il controllo.
Il soldato partigiano doveva essere maschio, virile, mosso da ideali di giustizia e di libertà. Doveva essere fiero ed epico. Se moriva, moriva gridando «Viva l’Italia!» o «Abbasso il fascismo!». La divisa in ordine, i baffi curati, lo sguardo proteso verso l’avvenire. Visto che le truppe partigiane sul campo erano composte da una sorta di eterogenea armata Brancaleone guascona e ribelle i grattacapi per la propaganda dovettero essere moltissimi. Le istantanee dovevano restare nei cassetti di chi le aveva scattate, e a quel punto quando moriva un combattente esso veniva celebrato (fotograficamente) con l’unica foto che si era mai fatto fare in vita: quella del proprio ritratto, il santino. Ecco perché la storia fotografica della Resistenza è costellata di santini e non di giovani che si passano il fiasco di vino intorno al fuoco. Non perché non c’era il vino, ma perché nessuno lo ha fotografato. E quando lo ha fatto l’immagine non è stata utilizzata da nessuno, perché nessuno – neanche il fotografo – voleva modificare l’immaginario resistenziale che si andava affermando. Cioé il sogno che la Resistenza aveva fatto di se stessa. Battere il fascismo, sconfiggere i tedeschi e riprendersi il Paese (facendo fuori la monarchia). Roba da farsi tremare le vene ai polsi, altro che fiasco di vino.
Lasciate fuori dalla storia le istantanee di certo non si poteva costruire un immaginario solo con i santini, anche perché la tradizione cattolica si era già appropriata di quel modello. Quindi abbiamo un profluvio di sfilate partigiane il giorno della Liberazione, con divise pulite e stirate e i capelli in ordine (sfilate peraltro quasi sempre postume, effettuate nel 1946, ’47 o ’48 e le cui immagini sono oggi didascalizzate come «partigiani sfilano a Milano il giorno della Liberazione»).
Poi c’è il quarto scatto fotografico che nel tempo è andato a costituire un tassello importante del nostro immaginario resistenziale, ovvero le cosiddette «ricostruzioni». Le ragazze partigiane che «perlustrano» Milano, le squadre che danno la caccia ai franchi tiratori sui tetti di Firenze, e più in generale ogni singola immagine di combattenti intenti a sparare, sono dei falsi. Falsi realizzati per raccontare un’epica, quella partigiana, che era dolorosamente priva di immagini (o almeno di immagini utilizzabili dalla propaganda).
Nel tempo la memoria s’annacqua e la realtà come un sogno si confonde e collide con altre realtà. Terminata la necessità propagandistica non è mai terminata la necessità dei reduci di ricordarsi non come erano davvero, ma come avevano sognato di essere. Belli, puliti, con i capelli in ordine, lo sguardo fiero e proteso verso l’avvenire. D’altronde se anche i racconti, se anche gli «io c’ero» si contraddicono a vicenda, ognuno intento a raccontare ciò che ricorda, la sua verità, allora figuriamoci quattro scatti infilati in un cassetto quanto possono modificare il corso della storia.

Questo libro allora a che serve?
[dropcap]C[/dropcap]he fine ha fatto la gioventù ribelle nelle foto dell’immaginario resistenziale? Che fine hanno fatto soprattutto le donne? E gli stranieri? Dove sono le foto dei generosi slavi, dei russi, degli indiani, degli americani, degli inglesi, dei tedeschi stessi, dei cosacchi e di tutti gli altri che fuggiti dai campi di prigionia aderirono al sogno partigiano? Eppure è passato quasi un secolo. Gli archivi fotografici, già penalizzati dal principio propagandistico chiudono senza fondi, affrontando con dignità la fine che l’era dell’immagine totale ha deciso di riservargli. Eppure qualcosa succede: la rete. Non dagli archivi, di fatto inaccessibili, ma dai cassetti, escono foto. Morti i proprietari di quelle immagini ecco che i nipoti o in alcuni casi i pronipoti si incuriosiscono. Ecco nonna con lo Sten. Ecco nonno che fa lo sbruffone con gli amici, mentre assalta una caserma fascista. Ecco il prozio con le sue «amiche» mentre preparano l’esplosivo. L’esplosivo? Sì, che il prozio era un coso, un partigiano. Un partigiano?
Nonno e nonna erano riservati, perché anche se avevano combattuto conservavano una dignità e un pudore per ciò che erano stati. Aderivano all’Anpi e il 25 aprile erano sempre in piazza con il fazzoletto al collo. Ma di scucirgli una storia o una foto non c’era verso. Il prozio poi era proprio morto prima della fine della guerra, e tant’è. La rete, il web, l’internet insomma, sta restituendo le foto dei cassetti. Ogni tanto lo scandaglio, come si può passeggiare su una spiaggia dopo una burrasca, ritrovando oggetti che il mare restituisce con parsimonia.

Istruzioni per l’uso
1. Ci sono un sacco di foto di donne partigiane in questo libro.
Le donne sono state doppiamente emarginate dall’immaginario resistenziale. Lo standard femminile per gli anni Quaranta era rigidino. A casa a fare la calzetta che la guerra è una roba da uomini. Negli anni Quaranta – per dire – le donne neanche avevano il diritto di voto. In Italia le donne sono potute entrare nelle Forze Armate solo nel 1999. Eppure erano lassù, in montagna, con gli uomini. Non potendo ignorare questo fatto l’immaginario resistenziale le ha trasformate, sempre e invariabilmente, in «staffette». Eroiche staffette che pedalando di qua e di là superavano i posti di blocco in quanto donne e quindi inoffensive. Nessuno nega che il numero di combattenti femminili nelle fila partigiane fosse proporzionalmente inferiore a quello degli uomini. Ma negare l’esistenza delle combattenti, delle comandanti e delle commissarie politiche, è stata una crudeltà. Così come in tutto l’Occidente durante la Seconda Guerra Mondiale le donne si sono improvvisamente ritrovate nelle fabbriche a mandare avanti l’economia del paese, in Italia hanno combattuto come tigri per liberare la nazione. Le partigiane combattenti sono state 35mila, 1.070 delle quali cadute in combattimento e 2.812 impiccate o fucilate. Ma la loro memoria è stata rimossa. Finita la guerra, a casa a fare la calzetta, medesimo destino delle operaie britanniche o americane. Le fabbriche si sarebbero poi riaperte per tutti e tutte solo negli anni Sessanta.
Anelando a rappresentare l’«Italia migliore» per quelli che potevano essere gli standard degli anni Quaranta il cln ha sistematicamente isolato il contributo femminile alla Resistenza. I reparti che dovevano sfilare il 25 aprile avevano ordini di lasciare le donne in montagna, perché per il cittadino medio, quello che non aveva preso le armi, né da una parte né dall’altra, una donna in compagnia di uomini, vestita da uomo e che ne «scimmiottava» i modi guerreschi non poteva essere che una poco di buono. Quindi non si poteva dare quell’idea alla popolazione, l’idea che i «banditi» non fossero assolutamente irreprensibili sul piano morale.
2. Ci sono un sacco di foto cretine in questo libro.
In effetti c’è questa caratteristica imbarazzante per l’iconografia partigiana non solo di mostrare con un certo orgoglio le armi da fuoco, ma spesso di simularne l’utilizzo puntandole contro i propri compagni, con conseguenze a dir poco comiche. Questa caratteristica non si ritrova nelle foto di soldati dei vari schieramenti, evidentemente abituati all’uso e alla presenza di armi da fuoco, ma solo nelle formazioni partigiane. La presa delle armi, per chi aveva scelto di combattere l’esercito tedesco e quello della Repubblica di Salò, era evidentemente fondamentale, e sulla loro carenza e su quella delle munizioni ci si giocava la vita. Ostentarle, mostrarle con orgoglio, mostrarsi nel loro uso, per quella che – lo ribadisco per l’ennesima volta – poteva essere l’ultima fotografia della propria vita, ha un che di rituale magico e meraviglioso. Se oggi non ci sorprendiamo per certe ostentazioni di gadget tecnologici, o di griffe, o di comportamenti socialmente inappropriati e rivendicati dunque come tali, non dovremmo sorprenderci dell’affetto mistico che legava il partigiano al proprio fucile. Se in foto ci sono io, viene anche lui. E faccio pure vedere quanto è bello.
3. Molte foto sono venute male.
Sì è vero, chiedo scusa fin da subito ai cultori dell’immagine, ma la verità è che più una foto è brutta, scura, mossa, usurata e macchiata, più probabilmente è autentica. Le «buone foto» sono quasi sempre realizzate in posa, a bella posta per il fotografo. Ciò non toglie peraltro che possano «raccontare» la realtà più e meglio di quelle autentiche, peccato che la realtà che si è scelto di raccontare all’epoca soffriva dei difetti che abbiamo elencato fino ad ora.
4. Il sorriso dei partigiani.
Una delle conseguenze dell’idea di epica morale applicata alla guerra partigiana era (anche) quella di una mortale serietà. In effetti si può pensare che combattendo una guerra, perduti e isolati sulle montagne, o clandestini nella propria città, non facesse proprio morire dal ridere. Anche il già ampiamente descritto meccanismo di censura, esterna o interna, poteva contribuire. Insomma, il partigiano è uno serio, ma proprio serio serio, e nelle foto lo vogliamo così. Eppure di foto di combattenti che davanti all’obiettivo ridono felici è pieno. Perché erano giovani, perché stavano combattendo dalla parte giusta, per se stessi prima che per chiunque altro, perché stavano lì coi compagni e si poteva morire da un momento all’altro, allora questo sorriso stampato in faccia al mondo è un’ulteriore resistenza. Non scriverò mai se e come sono morti i partigiani di questo libro, che l’epica resistenziale è strapiena di assassinati, tutti indomiti, tutti coraggiosi, tutti «viva l’Italia!». Questo è il mio punto politico. Mi rifiuto di commemorarli nel momento della loro morte, li voglio ricordare vivi, il giorno che sorrisero al mondo.