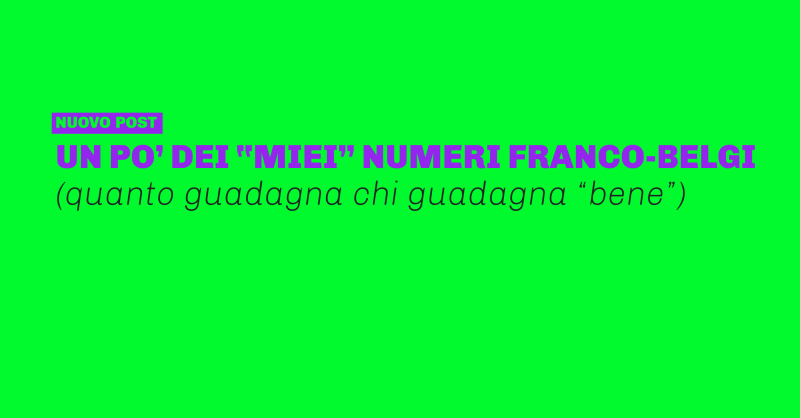[dropcap]S[/dropcap]ono un bambino degli anni Settanta, cresciuto con un modello narrativo interrotto. Da bambino a scuola leggevamo brani dall’«Antologia». Cioè pezzi di libri, di romanzi, di cui ti restava un vago sapore in bocca. D’estate si faceva man bassa di Tex usati alle bancarelle. Un fumetto a puntate, spezzato in più albi, che comprandolo così, spurio, restava eternamente senza inizio o senza fine. O senza entrambi. Poi c’era la televisione, con le serie animate programmate in maniera garibaldina, epopee infinite di robottoni o di orfani, delle cui storie, nessuno ha mai saputo la fine. Infine il cinema, dove la domenica pomeriggio ci si recava in pellegrinaggio, entrando quando si arrivava, a film iniziato, che poteva essere iniziato da poco o da tanto. La regola dalle mie parti era «sotto i venti minuti si entra». E poi si restava a vederne l’inizio allo spettacolo seguente.
Oggi, ovviamente, è «molto meglio». Le narrazioni hanno un inizio e una fine. Al cinema non si entra a spettacolo iniziato, e dopo ti cacciano via, non puoi restare a rivederlo. I fumetti sono diventati libri, iniziano e (più spesso) finiscono. Anche la televisione è cambiata, e le serie tv hanno un inizio e una fine e le cose sono tutte molto logiche e ordinate.
Vorrei trarre una qualche morale da tutto questo, ma l’unica cosa che mi sento di dire con una qualche certezza, è che da quegli anni di bambino ho ereditato una certa avversione ai finali. Non so scriverne e in generale non mi piacciono, perché le storie non finiscono mai. I protagonisti sono immortali, le loro avventure, eterne.